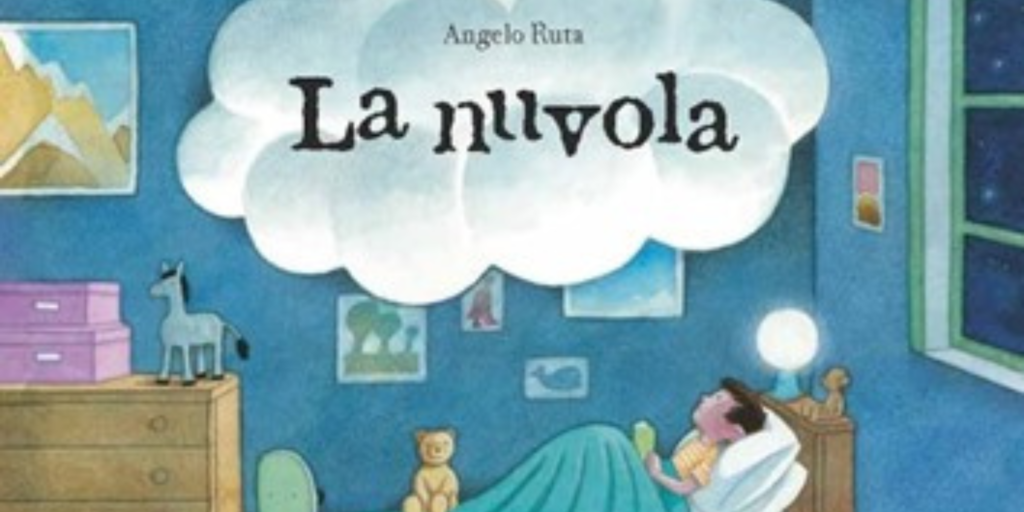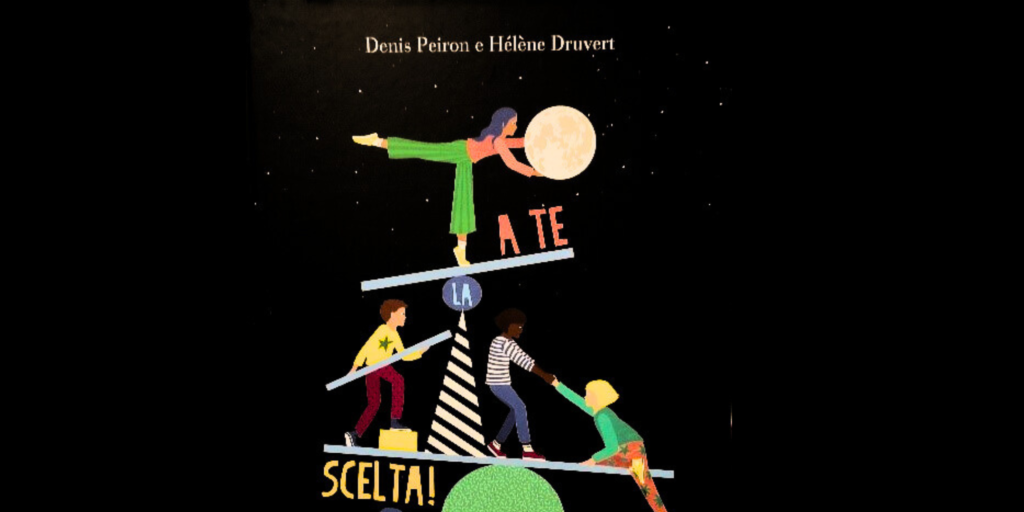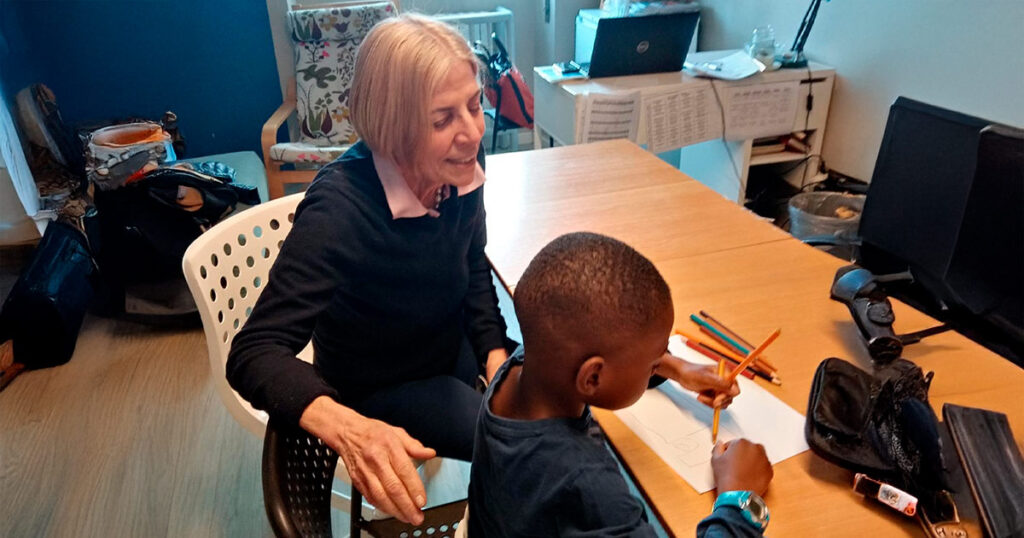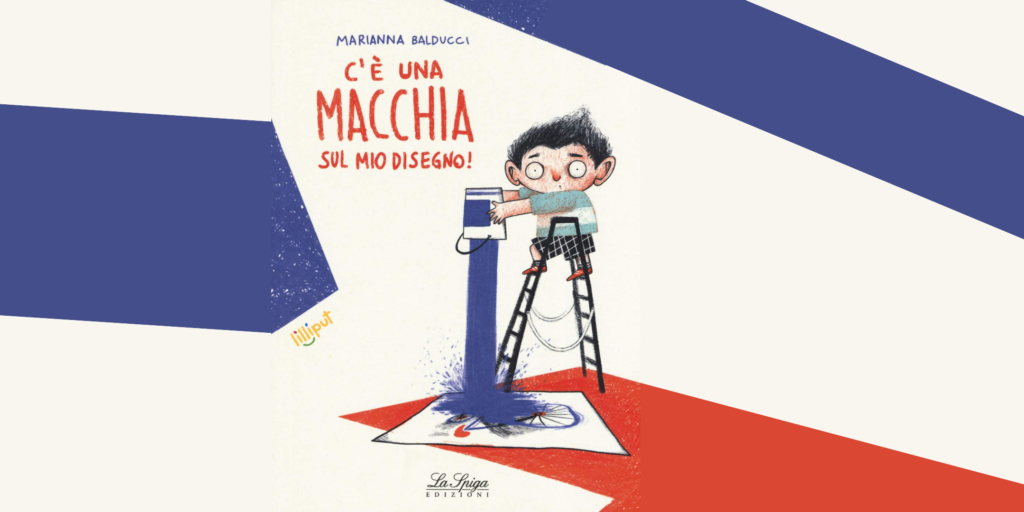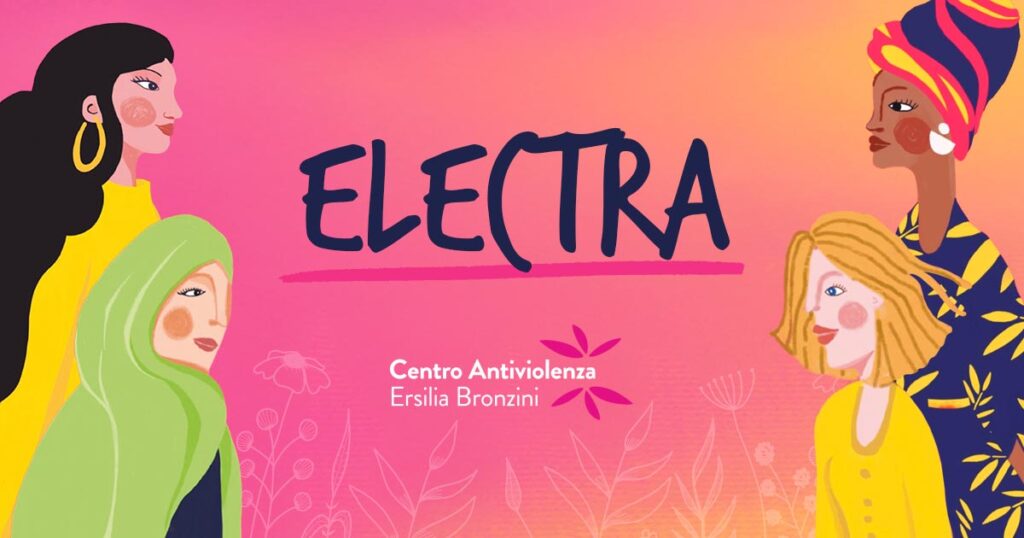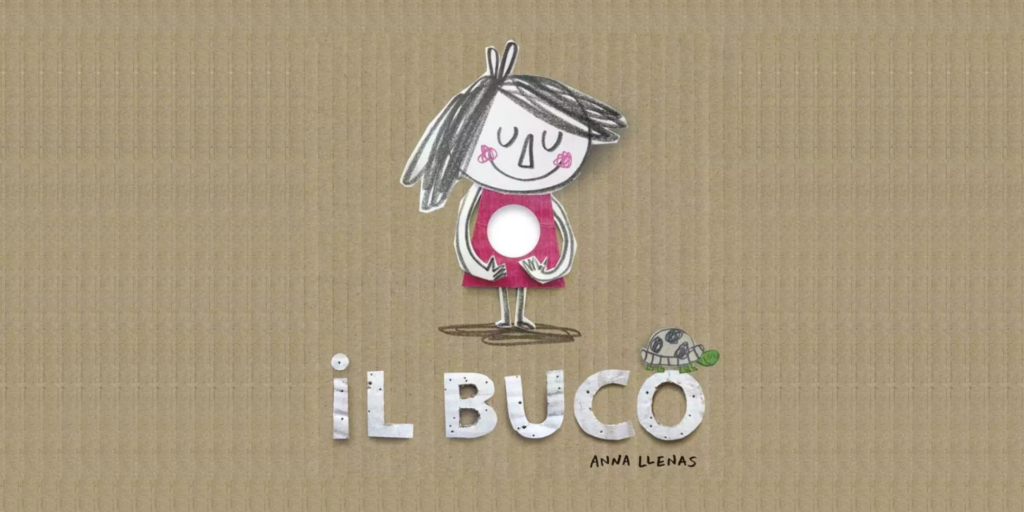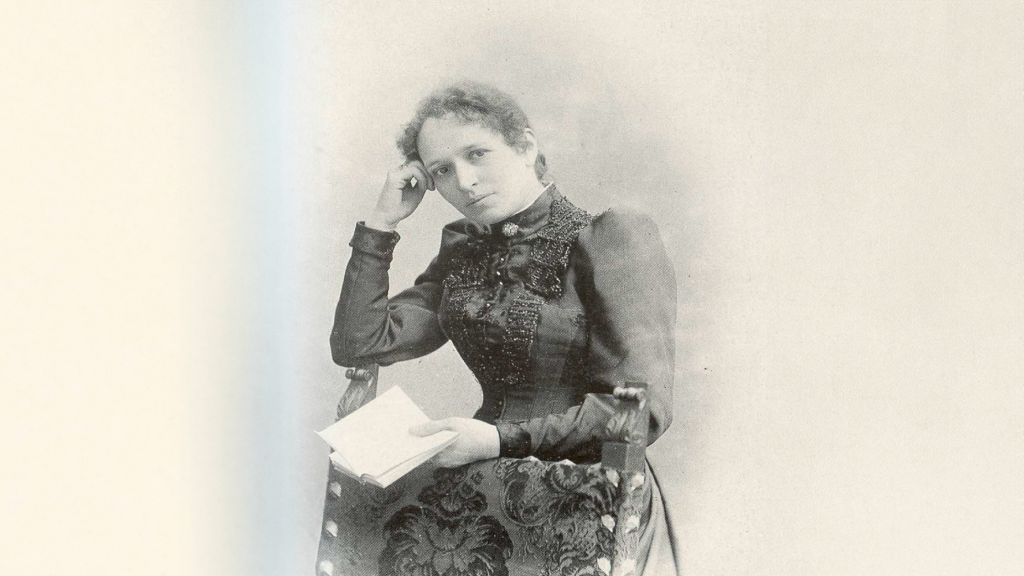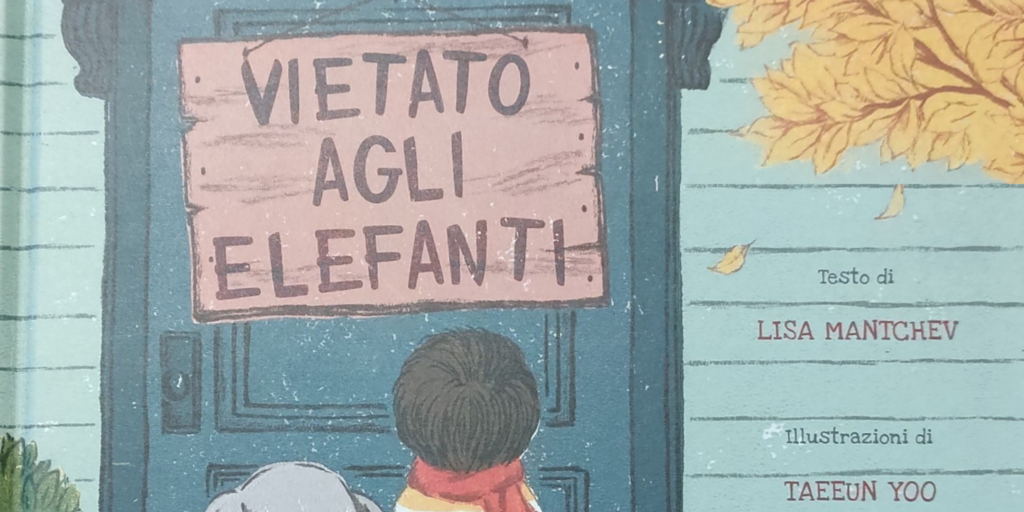Asilo Mariuccia è una Fondazione senza scopo di lucro. Operiamo, dal 1902, esclusivamente per fini di solidarietà sociale offrendo assistenza socioeducativa a donne e minori.
- Via Giovanni Pacini, 20 - Milano
- 02 70634232
- P.IVA 04826300156
- info@asilomariuccia.com
- asilomariuccia@legalmail.it
- CF. 80102590157
RIMANI AGGIORNATO
Iscriviti alla nostra Newsletter e ricevi per primo notizie, aggiornamenti e storie dalla nostra Fondazione.
| Thank you for Signing Up |

Visualizza la nostra privacy policy per l'utilizzo dei tuoi contatti
© Copyright 2024 - Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS - Powered by Deliverti