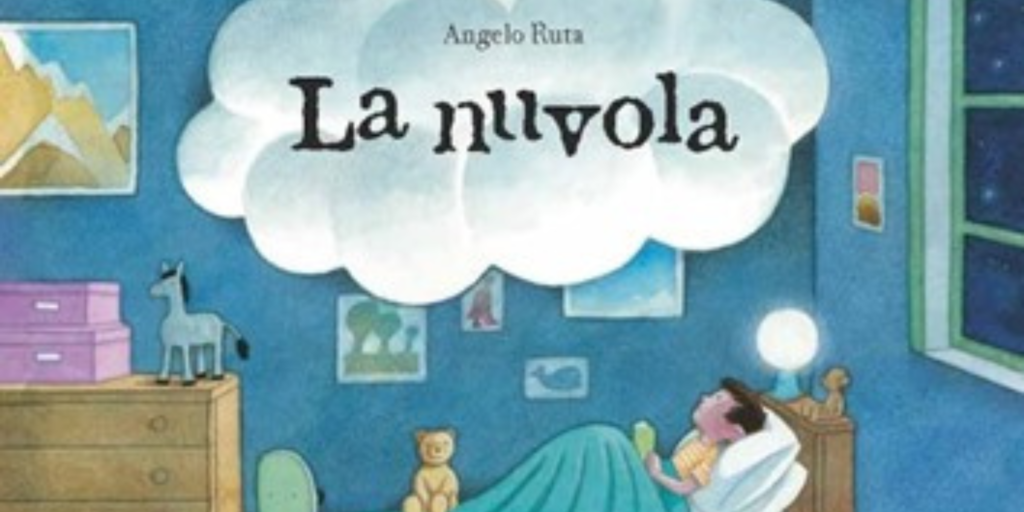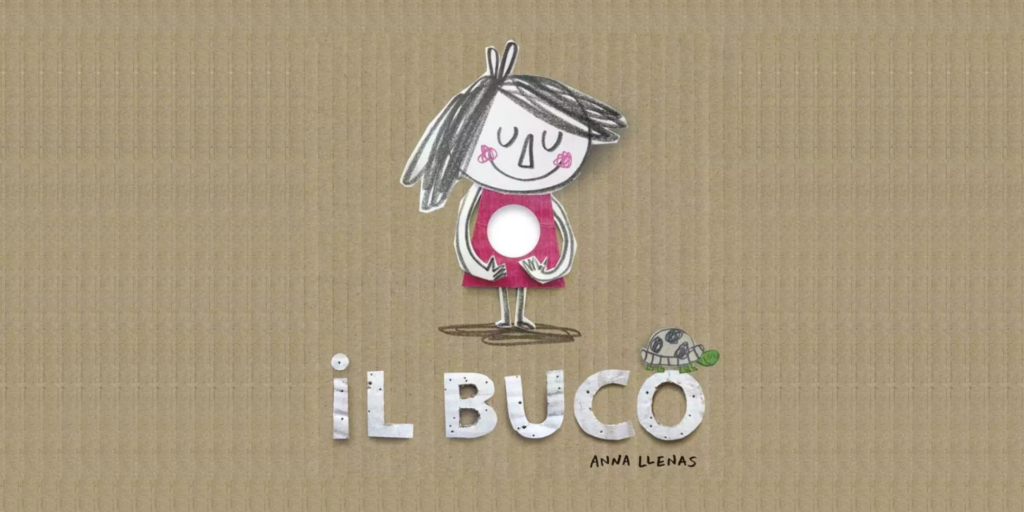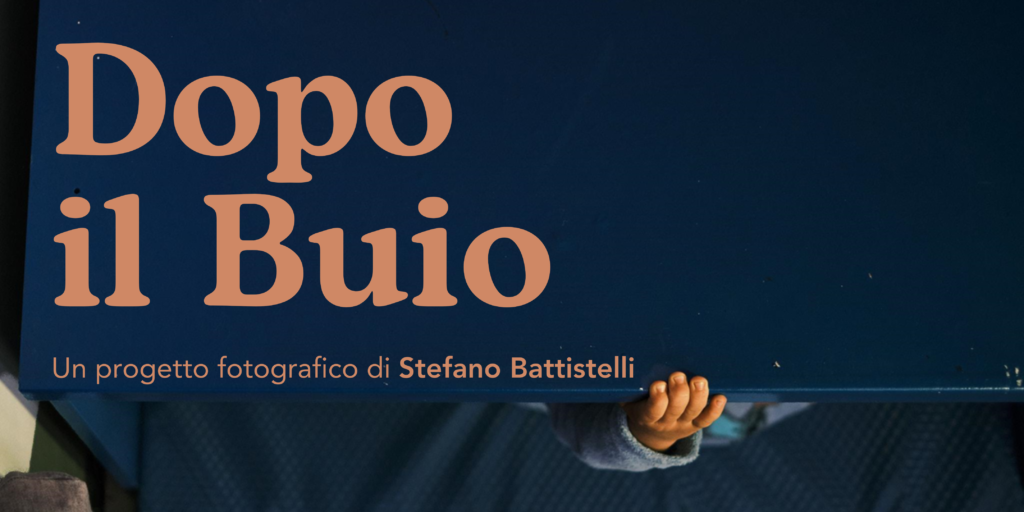MAGAZINE

La voce degli esperti
In punta di matita: osservare per accompagnare
Uno sguardo attento sullo sviluppo cognitivo, emotivo e simbolico dei bambini all’ingresso nella scuola primaria
Riccardo Scarparo
0 Comments
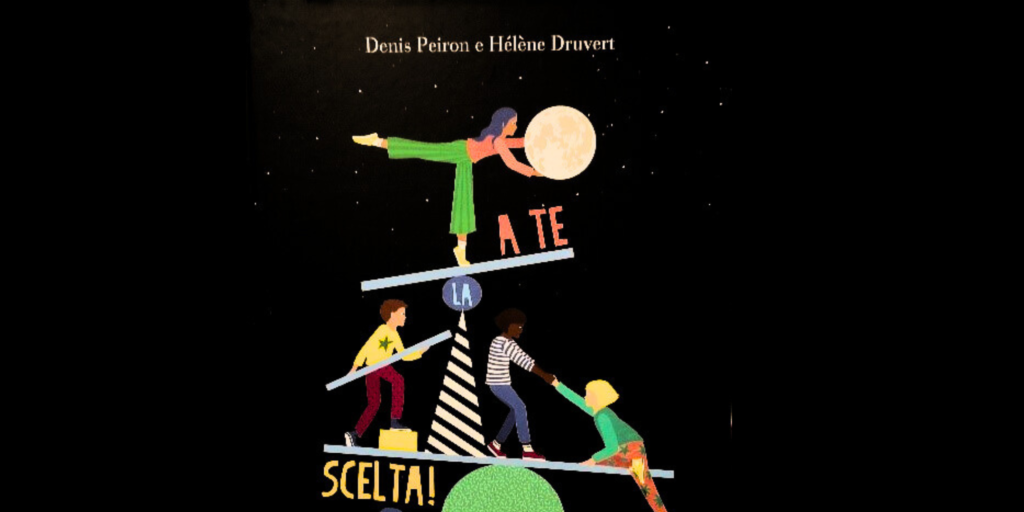
La voce degli esperti
A Te la Scelta
Consigliato da Fazia Rota, educatrice di FAM
a9d6c322_admin
0 Comments
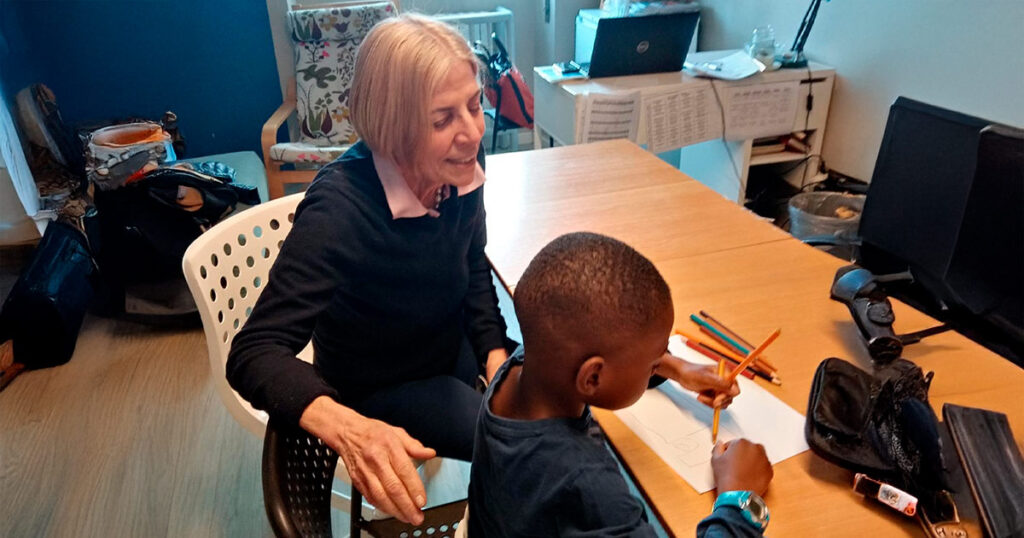
La voce degli esperti
In punta di matita: i magici cinque anni
Un progetto per rafforzare le competenze dei bimbi di 5 anni e prepararli con fiducia alla scuola primaria.
Riccardo Scarparo
0 Comments
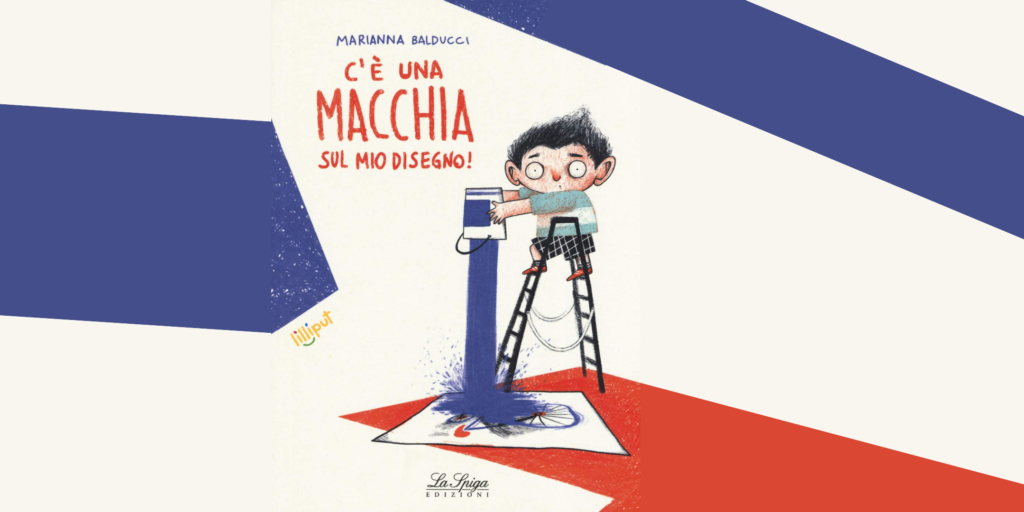
La voce degli esperti
Una Macchina sul mio Disegno
Consigliato da Maria Carlotta Padovani, educatrice di FAM
a9d6c322_admin
0 Comments

Porto Valtravaglia
“Coltivare inclusione” Fondazione Asilo Mariuccia estende i laboratori di educazione al lavoro ai giovani del territorio del Verbano.
Attivo il progetto rivolto a giovani italiani e stranieri del territorio, 10 ragazzi in formazione, fino a 34 saranno formati nel 2025.
Riccardo Scarparo
0 Comments
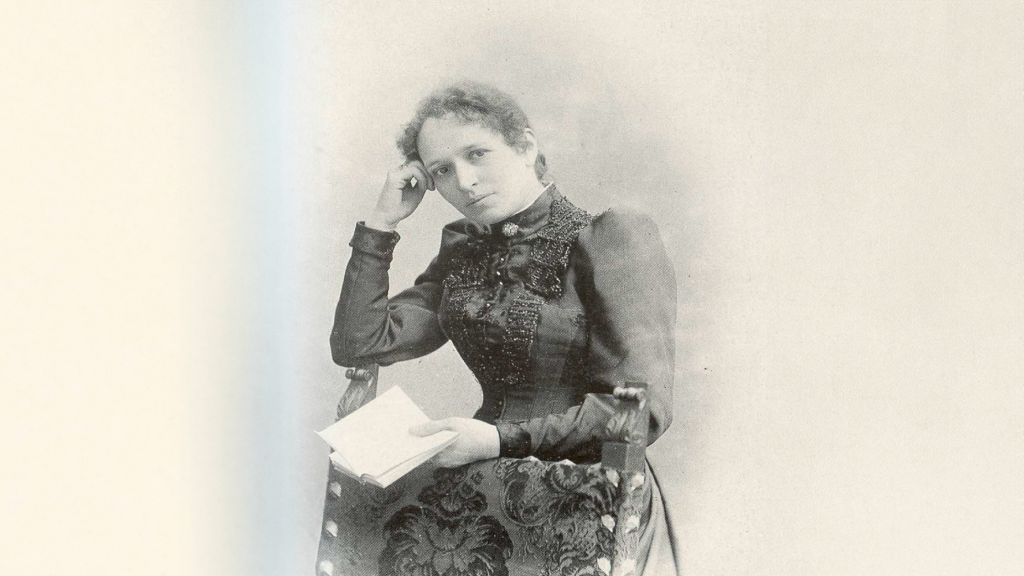
News
Fondazione Asilo Mariuccia: per e con le donne
Fondazione Asilo Mariuccia: per e con le donne “Abbiamo in comune come donne doveri per i quali è utile prepararci insieme e diritti che lavorando insieme potremo facilmente conquistare” Ersilia […]
nicric
0 Comments

News
Housing sociale “Apta Mihi”: inaugurate a Corbetta le prime cinque unità abitative
Si attivano da marzo, in provincia di Milano, i primi appartamenti destinati a donne con bambini vittime di violenza in uscita dai percorsi di accoglienza residenziale educativa
Riccardo Scarparo
0 Comments

Eventi
“Doposcuola al museo”: un viaggio tra cultura, gioco e inclusione
Il 10 Febbraio si è tenuto l'evento conclusivo all’ADI Museum, che ha celebrato il valore educativo del progetto e le sue prospettive future
Riccardo Scarparo
0 Comments
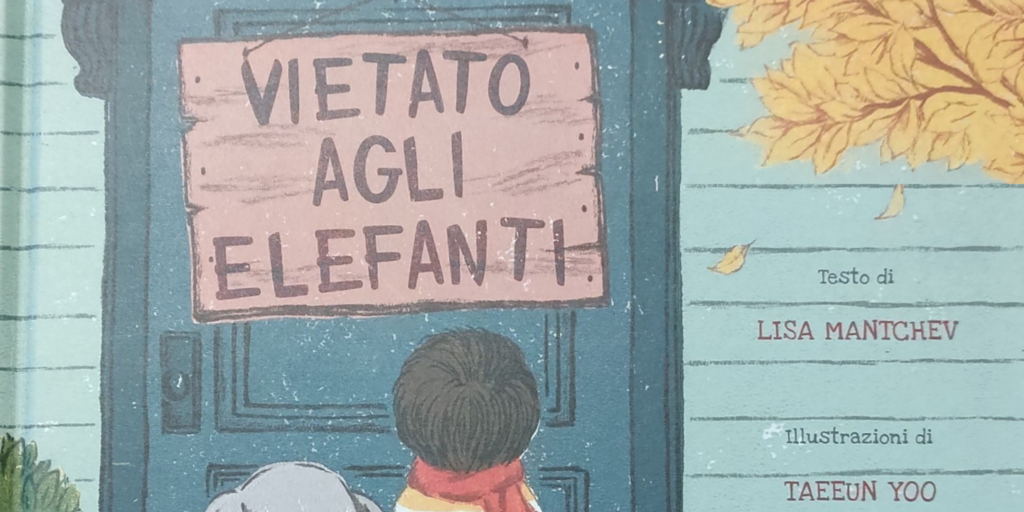
La voce degli esperti
Vietato agli Elefanti
Consigliato da Fazia Rota, educatrice di FAM
a9d6c322_admin
0 Comments

News
“Un porto nuovo”
In partenza il nuovo progetto di Fondazione Asilo Mariuccia per la ristrutturazione e la valorizzazione della storica sede di Porto Valtravaglia
Riccardo Scarparo
0 Comments

Eventi
PianeTiamo “Amare, amarsi, essere amati”
L'edizione di PianeTiamo di Febbraio è un inno all'amore in tutte le sue forme, in piena coerenza con il testo "Il mondo è tuo" di Riccardo Bozzi.
Riccardo Scarparo
0 Comments

La voce degli esperti
Un abbraccio vale molto più di 1000 parole!
A cura della Redazione di Fondazione Asilo Mariuccia
Riccardo Scarparo
0 Comments

La voce degli esperti
IntegrAzione: i laboratori di carpenteria navale come palestra per l’inserimento lavorativo di minori stranieri non accompagnati
A cura di Maurizio Mozzoni – Fondazione Asilo Mariuccia
Riccardo Scarparo
0 Comments

La voce degli esperti
Famiglie Favolose
Consigliato da Paola Zucchelli, educatrice di FAM
a9d6c322_admin
0 Comments

News
Il Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini
Un punto di riferimento sicuro per chi si trova in difficoltà
a9d6c322_admin
0 Comments

News
Uno spazio di incontro…tutto l’anno!
A cura della Redazione di Fondazione Asilo Mariuccia
a9d6c322_admin
0 Comments

Asilo Mariuccia è una Fondazione senza scopo di lucro. Operiamo, dal 1902, esclusivamente per fini di solidarietà sociale offrendo assistenza socioeducativa a donne e minori.
- Via Giovanni Pacini, 20 - Milano
- 02 70634232
- P.IVA 04826300156
- info@asilomariuccia.com
- asilomariuccia@legalmail.it
- CF. 80102590157
RIMANI AGGIORNATO
Iscriviti alla nostra Newsletter e ricevi per primo notizie, aggiornamenti e storie dalla nostra Fondazione.
| Thank you for Signing Up |

Visualizza la nostra privacy policy per l'utilizzo dei tuoi contatti
© Copyright 2024 - Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS - Powered by Deliverti